
Alessandro Fo, "Filo spinato"
In una tanto cortese quanto non obbligatoria risposta di Alessandro Fo a una mia mail, tra una parola e l'altra inerente la natura stessa del fare poesia, nonché del pubblicare con questa più che con quella casa editrice, confermavamo con l'autore Einaudi una sensazione di incertezza di fondo che velenosa si insinua e finisce per sbisciare in chi sceglie di andare a capo, conchiusa nell'espressione: cui prodest?
Dalla lettura di Filo Spinato (Einaudi 2021), pare si possa ricercare una risposta a quella domanda.
Leggendo infatti l'ultimo volume poetico di Fo, ci si imbatte in una continua riflessione su quel cui prodest, sul cosa farne della “nebbia di ricordi in versi”, riflessione sulla vita propria e altrui, così come su quella trasfigurata sulla pagina bianca, che è la poesia e l'arte in genere. Riflessione che viene approfondita man mano che ci si inoltra nella lettura, da eventi quotidiani, atti minimi, nugae, semplicità amene, morti comuni di cari e di sconosciuti, addirittura di sosia (Kay Kent)[1], da immagini di pin-up dal meccanico (chissà adesso in quali condizioni, se vive) da voci anonime in galera, che tutte, prima o poi (forse nonostante l'ausilio della poesia), andranno perdute. L'oblio implica una rassegnazione? Il poeta scrive così in Non rassegnandosi, dopo aver ricordato gli ultimi istanti di vita della nonna di un’amica, e dopo aver registrato senza infingimenti che “il ricordo / di quell'istante... […] fa / piangere. Dopo 28 anni. Ancora. […] D'accordo / è fatta in questo modo la Natura, / ma...”. Fermando il testo sulla struttura aperta lasciata dalla congiunzione avversativa, l'autore dà segno della strenua volontà della persona loquens di vivere e non rassegnarsi a un nichilistico oblìo, lottando anche contro quella che è la natura transitoria dell'essere mortali. La domanda iniziale può così trovare una prima risposta, sebbene aperta. Infatti quella di Filo Spinato risulta già a una prima lettura una poesia pronta a confrontarsi con il tempo che verrà.
Se analizziamo le sezioni della raccolta in un breve excursus possiamo notare come ci siano profonde concordanze interne, fili che si dipanano e intrecciano tra loro tessendo una trama fitta di rimandi: ognuno di essi è una tematica intrisa dalla presenza del tempo. Nella prima sezione emergono una serie di oggetti carichi di significato e storia, fin dal titolo della silloge. Il Filo Spinato è quello che ha permesso la vita dei discendenti salvando l'avo, la res reperta una borsetta trovata tra le macerie dal nonno di un’altra amica in guerra, cosa povera, ma ritrovata, fonte materiale primaria di narrazione storica, talmente importante da averla “riposta con così tanto amore” da non riuscire più a trovarla: è il tema caro all'ultimo Caproni, quello della Res amissa, del bene perduto perché troppo gelosamente stipato e conservato; se Caproni aveva lasciato la res come amissa perché smarrita, una volta che questa si possa ritrovare può dare ancora significato. Altri oggetti simbolici permeano soprattutto la prima sezione, mostrando ancora una volta il carattere di poetica dell'oggetto tipico dell'autore: Pagelle del 1934, lettere di Angelo Maria Ripellino (in)custodite dentro un garage che va passando di proprietario in proprietario, ancora non ritrovate: cose quotidiane e quasi dimesse, di natura personale, convivono con la memoria di persone comuni e non, diverse situazioni compongono la sezione iniziale Ingannare il tempo, che si configura (altra caratteristica di Alessandro Fo) come sguardo lucido e alto con cui osservare il mondo. È da notare come l'inganno non corrisponda mai a svago, a un divertissement col quale oggi potrebbe essere intesa l'espressione: è piuttosto l'inganno che l'uomo cerca di tramare contro la labilità di oggetti, evenienze, persone; se attraverso la poesia un oggetto può raccontare la sua storia, così come possono farlo due suore, un malato di Alzheimer, un ricco romano che permise a Sant'Agostino di proseguire gli studi ecc., allora si sarà riusciti nel supremo inganno, quello contro il tempo: dato che nulla può sottrarsi ad esso, che pure è tantum nostrum.
Come è suo uso, l'autore ci tiene a precisare riferimenti, luoghi ed eventi che hanno portato alla stesura di alcuni testi in una nota posposta alla silloge (Un appunto). L'esperienza del volontariato in carcere, che nasce su suggerimento di una ex allieva, come fonte di profondo arricchimento spirituale e umano, dà vita alla seconda sezione Muto carcere[2]. Quella di dar voce a chi voce non ha, vivendo all'interno di un mondo isolato, dall'esterno guardato con sospetto, ritrosia, se non disgusto o disprezzo, è operazione già praticata da Milo De Angelis nella sezione Alta sorveglianza di Incontri e agguati (Mondadori 2015). Funzione civilizzatrice e conoscitiva della poesia dunque, che giunge ancora oggi attraverso voci diverse: incontrare l'altro prestandogli espressione e sensibilità, modulate secondo il timbro proprio dell'autore, per poter far parlare persone e luoghi di confine; con la maestria di chi pratica la poesia da anni ed è capace di desoggettivare e universalizzare il dettato poetico, prediligendo, a livello stilistico, forme tendenzialmente lunghe nel rapporto tra respiro sintattico e semantico e alternando con abilità leggerezza e pathos. La sezione è drammatica quanto ironicamente triste, vive dell'italiano del poeta come delle traduzioni dal dialetto siciliano – talvolta riportate in calce al testo dialettale – mostrando una varietà che giova al piacere della lettura.
Casi di coscienza è esempio di levità e problematica riflessione insieme: levità risultante dall'uso del settenario e dell'endecasillabo, dalle rime e dalle assonanze, dal tu con cui la voce narrante si racconta al poeta, dall'episodio in sé di gentilezza quotidiana, dall'uso di un linguaggio colloquiale, dall'andamento narrativo del breve testo; problematica e attuale tramite le due strofe conclusive, con i tre versi in parentesi che ancor di più paiono racchiudere l'evento quale straordinario strappo alla regola della clausura; gli ultimi due endecasillabi stravolgono, fulmen in clausula, l'intera struttura del testo fino a quel momento letto. Si riporta il testo intero.
“Pensa che andavo a Messa
e lì ai giardini, sulla scalinata,
mi è cascata in braccio una vecchietta.
'Mio Dio, signore, lei proprio mi ha salvata'...”
(era l'ultima sera del permesso
e tra poco sarebbe ritornato
nella gabbia che gli era destinata).
“Povera donna”, aggiunse, “se sapesse
fra quali braccia era capitata”.
Si dia una lettura anche a un altro testo di ariosa leggerezza, Casette da presepe, che in sé racchiude bene quella caratteristica che è il rapporto tra aspettative e realtà (tralascio gli echi più o meno trasparenti di Pascoli e Leopardi per rendere al lettore il piacere dell'eventuale riscoperta).
Al mio primo permesso ho chiesto a mia moglie
che mi portasse a Castel San Gimignano.
Io volevo visitarlo. È il paese
che vedo dalla cella.
Tutti questi anni l'ho studiato nei dettagli,
per quanto posso dalla mia postazione.
Poi si fantastica, lo sai com'è. Nella notte,
con quei pochi lumini sparpagliati...
ti diventa il paesino delle fiabe.
Da un certo giorno in poi a una certa ora
s'alza il fumo dal solito camino,
si accende quella luce, in quella stanza.
Dato l'orario, sarà la cucina.
C'è un'ombra che si muove...
Una vecchina?
Un uomo solo?
Ti studi quelle vite
dimenticate. Diventano il tuo mondo,
fantasmi di persone,
la tua gente.
E poi ci sono stato di persona.
Me lo aspettavo, però che delusione:
due strade spopolate, l'abbandono.
A Castel San Gimignano non c'è niente.
A confermare la presenza di testi densi di pathos è possibile citare le testimonianze di condannati all'ergastolo, in cui risorge prepotentemente il tema dell'esilio dalla libertà, attraverso i Tristia di Ovidio e la figura di Achille: a dare conforto il mito, che consola e accomuna[3]: […] E, ci credano o no, / io non sono ormai più quello che ero. / Io fui già Achille che infiniti addusse / lutti un tempo. E io questo ben lo so. / Adesso sono l'anima di Achille / nell'Ade, che vorrebbe essere l'ultimo, / ma sulla terra. Anche servo, nei campi, / ma sotto il sole e i suoi splendidi raggi... [...]”.
L'attualità sempre drammatica dell'idea di non poter più uscire dal luogo in cui ci si trova, la disperazione generata dalla costrizione reclusiva (quella che in parte la pandemia ci ha costretto a sperimentare nei momenti di maggiore virulenza) e la speranza di poter riuscire a rivedere i propri cari è rappresentata attraverso casi di una umanità sofferente al limite del suicidio, ma che trova pure un motivo per sopravvivervi: “ […] Se cominci a temere / che proprio non potrai uscire mai più, be', allora, sai cosa ti dico, addio. / E io / mi ero già fatto ormai pure la corda. / ...Poi è venuta una suora e mi ha donato / un libro di preghiere... / mia moglie mi portò / la piccola a vedere. / lei mi abbracciò / e mi disse: / 'papà mio'.”[4]
Nell'ultima sezione riprendere again l'eponimo foscoliano (Dei sepolcri, again) significa suggerire in maniera esplicita la funzione di questa poesia, valorizzando il rapporto coi morti e coi posteri in maniera vicendevole. Si dia uno sguardo al testo Natale con sorella a Prima Porta, ove all'interno di un cimitero ci si interroga su quelle parentesi che sono i nostri nomi sulla terra (letteralmente, sulle lapidi): “[...] fragili dissolvenze / scrigni di piani, gioie, sogni futili, / meschinità ed accumuli / friabili. [...]” E se il discorso si apre come sorta di colloquio familiare (l'epigrafe porta la notizia della morte della madre recata dalla sorella) esso si amplia a respiro del mondo entro un più generico Parco del Ricordo disposto dal sindaco: lì si trova la foto “[…] di una donna che legge e intanto fuma, / e ancora non mi ha neanche nel pensiero. / Lei era e io non ero. / Ora io sono e lei (credo, lo spero) / lei, che qui non c'è più, è per davvero”.
Il rapporto dell'uomo con il proprio vissuto, con quello altrui, col tempo, coi morti e con gli oggetti è indagato lungo l'intero percorso del volume: quello che potrebbe sembrare a prima vista un simbolo di chiusura diviene un'opportunità: è il filo spinato che dà il titolo alla raccolta, e la poesia eponima è l'ultima del volume, la prima in copertina (si riporta la seconda parte del testo presente in copertina).
Dopo un assalto, rientrava in fretta,
ma al momento del salto, sotto i colpi
restò impigliato in un reticolato.
Bestemmiando contro i numi avversi
disimpegnava in affanno la ghetta,
quando una bomba gli sorvolò la testa,
finì in trincea al suo posto, e uccise tutti.
Senza quel filo, a cui noi siamo appesi,
niente Bianca né Dario, né Fulvio,
né noi nipoti né il premio Nobèl
[1] Il testo era già presente, come altri, nella silloge Esseri umani, L'arcolaio 2018.
[2] Lo apprendiamo, così come altre informazioni su altri testi, dalla nota a fine volume.
[3] Anime in pena, p. 49.
[4] Inferno e Paradiso, II. Corde, p. 61.
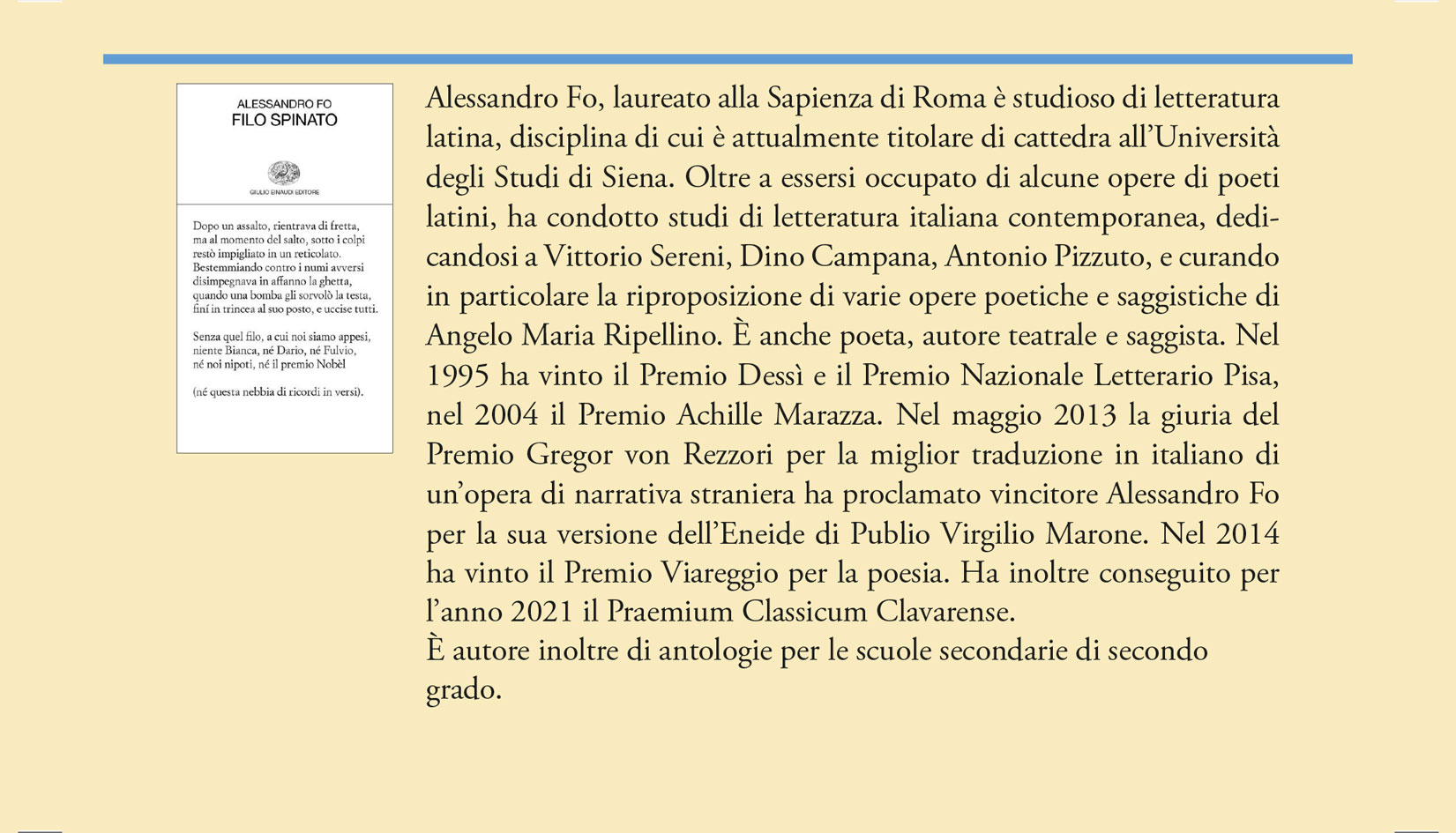


Sostienici

Lascia il tuo commento