
Eugenio Montale e le donne della sua produzione poetica
Su un poeta immenso come Eugenio Montale è stato scritto tantissimo, tutto o quasi, ci dovremmo chiedere a che cosa oggi possa servire tornare su di lui, ciò verrà rivelato nel corso dell’articolo. La carriera poetica di Montale, la quale è sì contemporanea all’ermetismo, ma scevra dei suoi tratti più estremi, non presenta quelle rotture presenti nella produzione ungarettiana. L’itinerario montaliano procede verso una sorta di approfondimento della visione della vita, anzi di una visione. Tale approfondimento che in sé, ovviamente, contempla anche quello poetico, è chiaramente definito sin dai primi componimenti e resta costante in tutta la sua produzione. Il punto di partenza dell’itinerario è segnato dalla raccolta Ossi di seppia. Pubblicata nel 1925, contiene al suo interno tutta la produzione dei dieci anni antecedenti [1]. In anni dominati dalla rivoluzione poetica ungarettiana, Montale si distingue sia per un lessico che mira a una precisione naturalistica, non ripudia la presenza dialettale e non ha ambizioni di tono alto e può far pensare in alcuni versi a Gozzano o Pascoli, sia per la predilezione per un tono discorsivo che spesso presta particolare attenzione alla descrizione, anche minuziosa. Anche le descrizioni paesistiche e paesaggistiche hanno una loro fisionomia ben precisa. Quello descritto è il paesaggio ligure svuotato di ogni seduzione/attrazione turistica. Gli elementi umani, con il loro peso corporeo e corporale, non sono ancora molti, la sua poesia si distingue però, anche, per le figure femminili. Tra le ispiratrici del Poeta la madre è senza dubbio la meno nota e studiata. Un personaggio dal carattere particolare, quasi sempre nell’ombra. A tal proposito ci sovviene in ausilio Gianfranco Contini: «fragilità apparente che suscita la protezione femminile: la sorella di poco maggiore Marianna prefigura tutte le donne che vigilarono sulla sua vita e sono registrate nel suo canzoniere». Montale era profondamente legato alle proprie radici geografiche e famigliari. A quel mondo antico, quasi di un altro periodo temporale, il quale lo legava alla sua fanciullezza trascorsa tra Genova e Monterosso. In tale contesto la presenza materna non può non avere un ruolo fondamentale. Le donne di Montale, con i loro nomi, ritornano anche nella sua passione per la musica e nei suggerimenti che egli fornisce agli amici musicisti. In Arsenio risiede intrinseco qualcosa che continua a vorticare intorno alla questione delle traduzioni [2]. Montale nel 1928, mediante due lettere scritte a pochi giorni una dall’altra, suggerisce a Nino Frank [3], per rendere il “ritornello di castagnette”, la formula soudaine éclat e spiega lui che quel suono di nacchere è il primo segno che il tempo esce di squadra [4]. C’è da chiedersi perché «proprio les castagnettes nella Carmen di Bizet hanno esattamente questo compito, mandare qualcosa fuori di squadra, i cuori, le vite, le anime. Quando mancano le parole, Tra la, la la la... Ta ra ta ta... Dioniso irrompe e non c’è più modo di fermarsi, si discende sotto una tromba di piombo, fino alla fine, fino alla morte» [5]. Nel lavoro la Ubaldini continua poi andando ad analizzare le donne letterarie di Montale. Ma tornando alla madre, quale gioco essa ha giocato, tra le tante donne?
C’è da dire che nella produzione montaliana l’affetto per le persone umili, spesso figure femminili, che lo hanno protetto con la loro umanità, con il loro calore, con la loro fede candida, è un elemento fondamentale e fondante [6]. Di Maria Bordigoni, la donna che restò sessantacinque anni a servizio della famiglia Montale, la cuoca che preparò sempre i loro cibi tanto da creare un gusto di famiglia, la famosa donna barbuta, conservò gelosamente una vecchia foto [7]. Maria fu per Montale una sorta di angelo custode, quasi una madre. Un’altra Maria montaliana fu la Finollo, che per decenni fece la custode della Villa di famiglia a Monterosso. Di lei si parla in La Casa delle due Palme. La madre però riveste un’importanza umana e poetica fondamentale per Montale. Ma chi era la madre, Giuseppina Montale Ricci? Una donna tenera che seppe sempre accogliere le ansie e i malumori del figlio, e che lo condusse a riscoperta costante di antichi valori di bontà e semplicità. La poesia A mia madre fu redatta nel 1942 e rappresenta una profonda riflessione sulla morte. La lirica fu, infatti, scritta dopo la morte della madre. Essa traspare tutta l’angoscia di un figlio che si sente privato dell’amore più grande, quello che cura e protegge in modo totale e salvifico. Il componimento fa parte dalla raccolta La bufera e altro edita nel 1956. Questa, senza alcun dubbio, risulta la più cupa, pessimistica e angosciante raccolta in tutta la produzione montaliana. In essa il “male di vivere” diventa tangibile e assume una dimensione cosmica, che va dal microcosmo montaliano devastato dalla morte della madre, al macrocosmo con un mondo in piena guerra [8]. In tale raccolta, due sono le figure femminili le quali svolgono un ruolo di primissimo livello, entrambe con un ruolo salvifico: la prima è Clizia, nome tratto dalle Metamorfosi di Ovidio che indica l’amata Irma Brandeis; la seconda è proprio la madre, divenuta un’ombra in transito nei campi elisi. Una lettura critica vede invece in Cinzia la presenza ancora tangibile della madre morta. In ausilio, a tal proposito, ci sovviene l’osservazione condotta dal critico Giovanni Mazzotta nel 1947, il quale notò che l'”ombra viva” presente in modo costante nella raccolta potesse non riferirsi all’allegoria della poesia o alla presenza salvifica della donna-angelo, ma che quella messaggera divina che guida il poeta attraverso la bufera del mondo in tempesta fosse in realtà la madre. Una sorta di fantasma poetico, ancora in grado di indirizzare lo stile e la vita del figlio. Tale teoria sembrerebbe avere una tangibile evidenza nella poesia Una voce è giunta col le folaghe, nella quale il Poeta evoca una misteriosa ombra femminile, «un’ombra viva», che ricorda una presenza virgiliana. L’apice lo si tocca però nel componimento A mia madre:
Ora che il coro delle coturnici
ti blandisce nel sonno eterno, rotta
felice schiera in fuga verso i clivi
vendemmiati del Mesco, or che la lotta
dei viventi più infuria, se tu cedi
come un’ombra la spoglia
(e non è un’ombra,
o gentile, non è ciò che tu credi)
chi ti proteggerà? La strada sgombra
non è una via, solo due mani, un volto,
quelle mani, quel volto, il gesto d’una
vita che non è un’altra ma se stessa,
solo questo ti pone nell’eliso
folto d’anime e voci in cui tu vivi;
e la domanda che tu lasci è anch’essa
un gesto tuo, all’ombra delle croci.
La madre rappresenta un esempio di coerenza, che ebbe un’esistenza modesta e silenziosa, interamente votata agli altri, e soprattutto a quel figlio che all’età di trent’anni aveva deciso di allontanarsi da casa per cercare la sua strada.
__________________________
[1] D. Valli, Montale, Saba e la poetica dell'oggetto, in rivista Letteratura, n. 79-81, 1966, pp. 23-38..
[2] A. Gareffi, I ritmi della mente di Montale, in Sincronie, anno VII, n. 13, 2003, pp. 85-97.
[3]. Nino Frank (Barletta, 27 giugno 1904 – Parigi, 17 agosto 1988) è stato uno scrittore, conduttore radiofonico e critico cinematografico italiano. Testimone della vita letteraria e artistica, si dedicò con eclettismo al giornalismo, alla traduzione, al cinema e alla radio. Particolarmente attivo negli anni trenta e quaranta, Frank è conosciuto soprattutto per esser stato il primo critico cinematografico ad usare l'espressione "film noir" per riferirsi ai film polizieschi americani degli anni quaranta, come Il mistero del falco. Si veda: Le Bruit parmi le vent. Paris, Calmann-Lévy, 1968.
[4]. Lettere a Nino Frank, a cura di F. B. Napoletano, in Almanacco dello specchio, 12, 1928, pp. 18-64.
[5] C. Ubaldini, I nomi e le donne, in un solfeggio. Sul mottetto “L’anima che dispensa...” di Eugenio Montale, in Mosaico, 2012, pp. 7-11.
[6]. A. Frasson, Poesia e poetica di Eugenio Montale, in L'osservatore politico letterario, anno 27, n. 10 1981, pp. 49-60.
[7]. Montale a Monterosso, in Alidicarta, https://www.alidicarta.it/testo/71220201162684.
[8]. E. Montale, La bufera e altro, Milano, Mondadori, 1961.
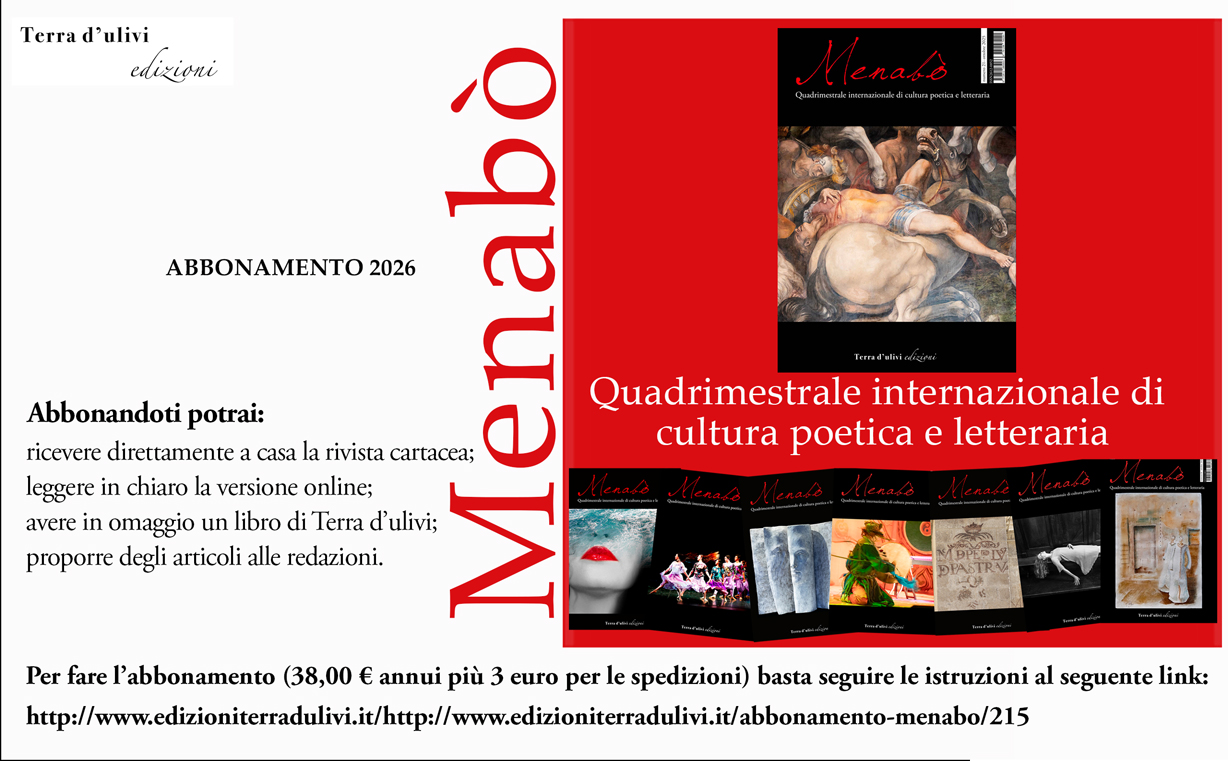
Sostienici

Lascia il tuo commento