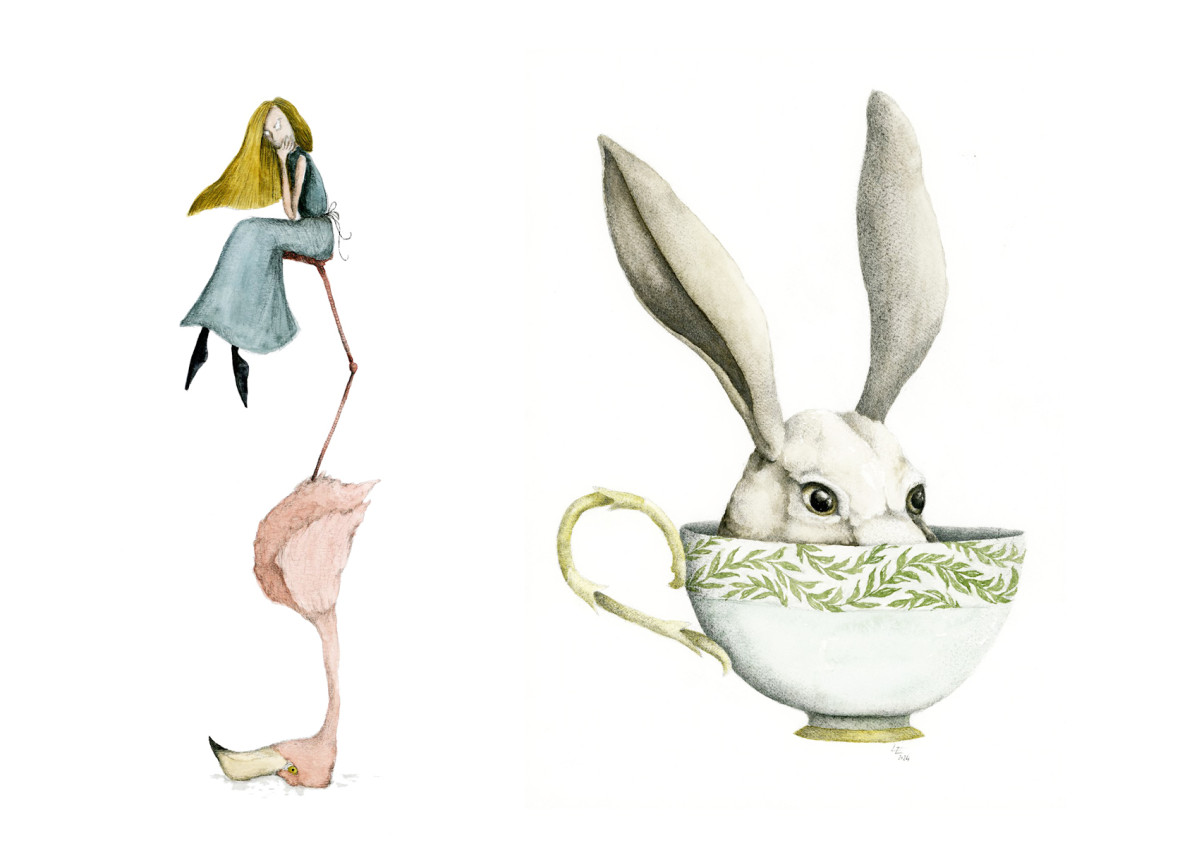
La luce dell'ecclissi di Vincenzo Frungillo
Durante l’eclissi, l’occhio è indotto a guardare il sole, al suo margine che pare smarginarsi nel fuoco, la pupilla ingannata dall’imbrunire si dilata, ma i raggi non sono meno aguzzi, accecano. In questa rottura dell’ordinario riusciamo quasi a guardare il margine ultimo, i confini del sole: fuoco, luce, dolore: differenza.
La luce dell’eclisse
paralizza, ferisce.
È presenza fisica,
riempie la vita.
Solo la luce può zittire.
Solo la luce può dire.
La luce dell’eclissi non dirada, come la radura di Heidegger, ma affila, rende i nostri occhi aguzzi.
[…] è ciò che spera, affila l’idea, ci lavora
approssima la forma, l’avvicina all’orizzonte
- deve sopravvivere agli eventi -
gioca di fino, assottiglia il simulacro,
ora è un riparo, un recinto, mette a fuoco,
la prima immagine che vede è un cerchio,
con dentro un altro cerchio […]
In questa opera di Vincenzo Frungillo ci dà prova di una espressione assai meditata, di uno stile magistralmente usato per esprimere con l’esattezza del margine una materia assai complessa. L’uso del sonetto, assai caro a Frungillo, - col suo contrarsi e dilatarsi – domina l’opera, ma, in modo sapiente, troviamo stralci di prosa poetica, frammenti e forme brevi che non sono un abbandono della forma, ma controllo massimo: nel terzo atto, scena terza, il poeta chiama le cose ad essere.
In tutta l’opera dialoga con Heidegger, non solo la radura diviene eclissi ma troviamo la dipartenza e la chiamata, il linguaggio come casa dell’essere e la riaffermazione della parola “La parola è inizio di ogni cosa./In sua assenza è tutta pianura/che la mente non sopporta.” perché se la poetica dell’azione e del media ci dominano, bisognerà pur dire che senza parola restano entrambi orfani del pensiero. Heidegger ci dice che il linguaggio parla, l’essere umano dimora nel linguaggio, la poesia nomina le cose, ovvero, non distribuisce nomi, ma – appella ciò che è lontano a farsi presso – invita le cose ad essere veramente tali per l’essere umano.
La luce dell’eclissi unisce questioni ontologiche e etiche (essere e agire), a quelle gnoseologiche (l’intuizione e la percezione della carne) e la memoria.
Così ci si suggella al porfido,
si spalancano i cunicoli al vento,
si ascolta l’animale riverso
sui tempi antichi del mondo,
lo si vede cercare il sentiero,
animare i primi suoni del verbo
con un’intuizione precosciente,
che accosta la veglia al sonno;
così si allunga la linea della vita
oltre il palmo di una mano,
a segnare la riserva di carne
alla quale affidiamo
la luce immobile dell’inizio.
Frungillo, giustamente, riporta tutte queste questioni all’essere, al primato dell’ontologia: “l’essere-di-mezzo//che graffia la roccia/segna il solco sul muro/dal quale parla il buio”. Chiama la roccia alla parola, alla significanza del segno, dal quale il buio parla. Frungillo ci dimostra che la parola poetica, nonostante il potere d’adunare significati, possa essere precisa, invito all’essere. Potrebbe essere altrimenti? Potrebbe essere il suo contrario? Hegel afferma che la voce dell’animale è inarticolata, capace di esprimere uno stato determinato senza parole, come un dolore lacerante o la morte. Infatti, nella morte violenta, l’animale esprime l’abolizione (Aufhebung), la propria abolizione. Diversamente dagli esseri umani, un animale può “dire” la propria morte, esprimendosi come rimosso (als aufgehobenes Selbst). L’animale colma la distanza tra sé e l’uomo, rimuovendosi come animale perché, una volta per tutte, emette la voce che dice la morte. La sua voce significa morte. L’essere umano, non può, non può né esprimerla né, tanto meno, pensare al vuoto “È questo il dramma,/se pensi al vuoto, lo riempi”, scrive Frungillo nella stessa poesia.
È lui l’uomo al centro della scena
con la tempia quasi bianca
mentre proiettano sullo schermo
bestie in assetto di guerra.
Lo aspettano sulla pianura,
lui non ha paura,
resiste al sentimento moderno,
non ascolta la parte del cervello
predisposta all’istinto della fuga:
«L’amigdala è anche pietra lavorata,
utile alla caccia e alla difesa.»
Ogni forma ha in sé il suo rovescio,
è una vendetta che lega alla terra,
così la parola che copre metre dissotterra.
E allora l’umano può non ascoltarsi, animale e civile, può rimuovere la storia dalla propria memoria. Non il poeta, la sua parola densa e lucente allo stesso tempo è la ricerca della verità, non solo del presente attuale o prossimo, ma della storia. Questa è un’operazione che a Frungillo riesce particolarmente bene, ne ha dato prova in altre opere legate alla DDR. Qui si legga l’atto dedicato a Sophie Scholl, anche questo è la luce dell’eclissi, e in questo senso la storia si fa presente attraverso la poesia, si fa presso; Frungillo la chiama presso di noi, la voce del poeta chiama ascoltando. La luce dell’eclissi è la parola che chiama storia e verità ad agire su di noi, a significare: “la parola che copre mentre dissotterra”. Non potrebbe essere più attuale, in una marea di dissenso mediatico a buon mercato e di gole tagliate, la parola del poeta è ricerca e pietra.
Sostienici

Lascia il tuo commento