
Mauro Ferrari, Seracchi e morene
Poeta, scrittore, traduttore, editore, Mauro Ferrari è persona impegnata da lungo tempo su più fronti del panorama culturale. La sua produzione poetica annovera titoli significativi e più volte premiati (Forme, Al fondo delle cose, Il bene della vista, Vedere al buio, La spira). Seracchi e morene (Passigli, 2024) è la sua ultima silloge in ordine di tempo ed è quella che raggiunge l’apice dopo un lungo percorso che in qualche modo ha in sé tutte le precedenti. A tale proposito significativa risulta l’osservazione che Giancarlo Pontiggia fa nella prefazione quando a proposito dell’ultima poesia osserva come essa raccolga tra i versi i titoli delle precedenti raccolte quasi a comporre, con le parole, un polittico.
C’è, tra le poesie comprese in questa silloge, una poesia che si caratterizza per l’afflato emotivo che la sorregge, perché costruita sul bisogno di pensare a un rifugio, a un argine dal quale estromettere ogni specie di insidia, a una sorta di protezione in cui rinchiudere una esistenza fragile, a un riparo per chi si ama e non si vorrebbe ferito dalla negatività della sorte che dilaga ovunque. È la poesia che il poeta dedica alla madre in cui, mentre si contempla un intenso e premuroso affetto tra le parti, non manca quella visione del mondo che è diffusa in molti degli altri testi della raccolta. Anche qui è forte infatti un pensiero che percorre l’opera intera, suddivisa in quattro sezioni, a stabilire diversi modi di approcciarsi alla realtà nei suoi vari aspetti, la storia, la natura, ma anche le responsabilità umane e quel senso di disfacimento, di risoluzione in nulla che è pregnante nell’opera di Ferrari. Nella poesia citata infatti il poeta ribadisce che tutto fuori come noi va in polvere… là fuori si sciolgono i ghiacciai…la terra si sfarina in polvere. Il fuori cui fa riferimento il poeta è il mondo complesso della realtà umana, storica e naturale, tradotto nella sua visione poetica, un mondo di cui parla con linguaggio asciutto e preciso, in testi cui non manca una musicalità composta, quasi riservata, e in cui è percepibile una sorta di sgomento per l’accadere dei fatti storici e delle vicende umane. È un mondo in cui domina un senso di dissolvimento, di sgretolamento, di nulla appunto, tanto che la parola nulla è ripetuta più volte in tutte le sezioni a evocare la distruzione, l’annientamento, il disfacimento, l’erosione, il vuoto, come se si avvertisse un pericolo, una minaccia incombente che è della storia e della natura insieme.
A questo senso di disfacimento Mauro Ferrari oppone a partire dal titolo stesso della raccolta, Seracchi e morene, che è anche il titolo della sezione in cui è pregnante la riflessione sulla natura, l’immagine della roccia, emblema di realtà solide, compatte, cui il poeta attribuisce una sorta di valore rappresentativo. Non per niente in esergo a questa seconda sezione, Ferrari riporta un verso del poeta inglese Ted Hughes che dice “la roccia persiste come nulla al mondo”. E alla durezza della roccia che non soffre la sua logica/e accetta come giusto fato/la pioggia, il gelo, si contrappone lo scricchiolio dei mondi/che fremono per divenire/e presto sfarinarsi in nulla, il tutto che sereno va/nella follia del nulla.… il nulla che avanza. Qualcosa di solido dunque, di resistente, che non cede facilmente sotto l’urto di oscillazioni improvvise, qualcosa che spesso indica anche l’immobilità a contrastare un divenire spesso convulso e disordinato. Che è della storia, tema cui Ferrari dedica la prima e la quarta sezione dell’opera, in cui scioglie tutto il suo sgomento, il tormento per realtà che implicano il dramma e la fatica del quotidiano, ma soprattutto la visione di una umanità cui non mancano nemmeno forme di dissoluzione morale (la pandemia del cuore e delle menti). Così il peso della storia si avverte nell’uomo che in fuga dalle raffiche/copre gli occhi al figlio, nella donna che pensa d’essere infine…salva, ma anche nel contrapporsi di situazioni diverse in cui l’amarezza si avverte profonda nell’antitesi di due mondi dove c’è un lui che aveva abbandonato casa…che in mare aveva perduto…due figli e la sicurezza di chi esce con le mani salde sul carrello della spesa, a rappresentare vite difformi nell’intervallo tra un nulla che precede e un nulla prossimo a venire. Ma la storia mostra il suo lato oscuro in molti modi, a volte concentrando la sua azione drammatica in precisi ambiti geografici dando vita a una realtà spettrale e desolata. È quanto il poeta ci enuncia nella quarta sezione, La spira, a cui ha dedicato un intenso lavoro di revisione durato anni e in cui il processo storico, emblema di una progressiva contrazione e poi di una quasi totale dissoluzione finita nel fumo, acquisisce una sorta di destino simile agli umani, la spira si raffredda come noi, indice forse di una comunanza di esiti cui ogni cosa è votata per sua intrinseca costituzione, tranne la roccia appunto cui arride uno sfacelo più lento e combattuto. Quanto mai eloquente il testo VII della sezione La spira. C’è in tutto questo un pessimismo di fondo, una negatività irrimediabile, il timore di un inganno, il senso ineluttabile del finire delle cose (tutto franerà in un balbettio), ma soprattutto della storia, di una fase della storia (grida ogni strada nomi vuoti e misteriosi/che la storia ha raschiato via) in cui (la terra ci riassorbirà impassibili) emerge la consapevolezza che a garantirci l’esistenza è il pensiero, il nostro pensiero, o meglio il pensiero di noi. È un pessimismo certo, assodato, si direbbe quasi originale, non sorretto da alcuna forma di fede, semmai critico nei confronti di alcune fonti religiose, non sopravvenuto in virtù dell’evoluzione di un pensiero o di un qualche drammatico, improvviso accadere (Fra noi e l’orizzonte promesso/è filo spinato). E c’è nella storia una innegabile responsabilità umana, ed è quando l’operato degli uomini ricade drammaticamente sulla natura e ne deforma o ne annienta l’esistenza, in una imperdonabile manifestazione di superbia (sono inetti che si credono/in cima alla catena alimentare).
Ma il nulla di Ferrari non richiama alcuna forma di nichilismo: È un nulla insito nel divenire delle cose e della vita, come anche nei sogni che hanno alimentato le utopie della giovinezza, pure esse finite in nulla (La polvere dei sogni si depositava/rapida), perché lo spazio si espande …andando in nulla, un nulla ateo, asettico, dentro al quale noi siamo pensiero, un nulla al quale noi dobbiamo opporre la stessa forza della roccia, stare come roccia ferma che non crolla per vicende storiche o vicende naturali.
Sia pur preponderanti in sezioni diverse, storia e natura finiscono per intrecciarsi, per evidenziare l’inanità dell’azione umana destinata a risolversi in nulla, un nulla ontologico che è sostanza stessa di una esistenza che è breve parentesi tra un nulla iniziale e un nulla finale, e in cui si consumano ingiustizie, perdite, dolori, eclissi di processi produttivi, guerre e pandemie.
Ne consegue la necessità di una resistenza che non è storica ché la storia e la vita/non danno seconde opportunità, e tutto approderebbe nuovamente in nulla, quanto piuttosto una resistenza etica ed estetica (dobbiamo resistere /amando la bellezza, crearla se possiamo,/ proteggere la sua fragilità/ e il vero e il giusto) in versi che scivolano fluidi e densi con profondità di pensiero e linguaggio concreto, solido, alieno da eteree allusioni e fragili compiacimenti. Ci sono insomma, tra il diffuso catastrofismo dell’opera, positività che assumono un valore etico, in particolare quello espresso nella sezione Infine dove il poeta dichiara che saranno solo/gli attimi incandescenti/a dire il nostro nome, quelli cioè che ci consentiranno di superare con una forza che può essere solo umana la invincibile forza della storia e della natura.
Mamma
Non è che fuori accada molto, le dico
quasi sentendomi in colpa per una vita
che scorre via di qua e di là dal vetro
che ci separa nel salone freddo.
Mi chiede qualche moneta per il tè
-abbiamo ancora soldi?- e un po’ di frutta
scrutando nei miei occhi se anche me
divora il tempo, orgogliosa dei suoi capelli
“ancora tutti neri”.
Che dirle, come dirle
che tutto fuori come noi va in polvere
impercettibilmente e che una perfezione
mai raggiunta vira al nero,
e il nero si fa grigio e bianco,
e poi sarà una trasparenza
e poi una parola, un’ombra contro il muro,
un’eco.
No, là fuori si sciolgono i ghiacciai,
non oso dirle, la terra si sfarina in polvere,
qualcuno muore e altri fingono
di vivere, ma io devo scappare,
tu resta qui, al riparo.
dalla sezione Sotto le bombe
XII
E pensano che in fondo,
a dirla tutta, ben poco è andato perso
nella bufera che ha sgrondato i rami
e ripulito i fossi della loro storia:
frutti difficilmente commerciabili
il dodo l’alca il lipote il tilacino,
una manciata di tribù ostinate
con lingue primitive e barbare.
(Questa è la voce che gira a fondo valle).
dalla sezione Seracchi e morene
Ma poi saremo vecchi,
e troppo per ammetterlo,
la mente carica di immagini sfocate,
in tasca sassi neri e pochi bianchi;
e non ci importerà più molto
quanto avremo avuto, e cosa dato,
perché saranno solo
gli attimi davvero incandescenti
a dire il nostro nome.
dalla sezione Infine
…
Oggi i laghi sono gelati, i torrenti in secca,
tutti i sentieri impraticabili
ed ogni rotta cancellata dalle mappe:
grida ogni strada nomi vuoti e misteriosi
che la Storia ha raschiato via.
…
dalla sezione La Spira
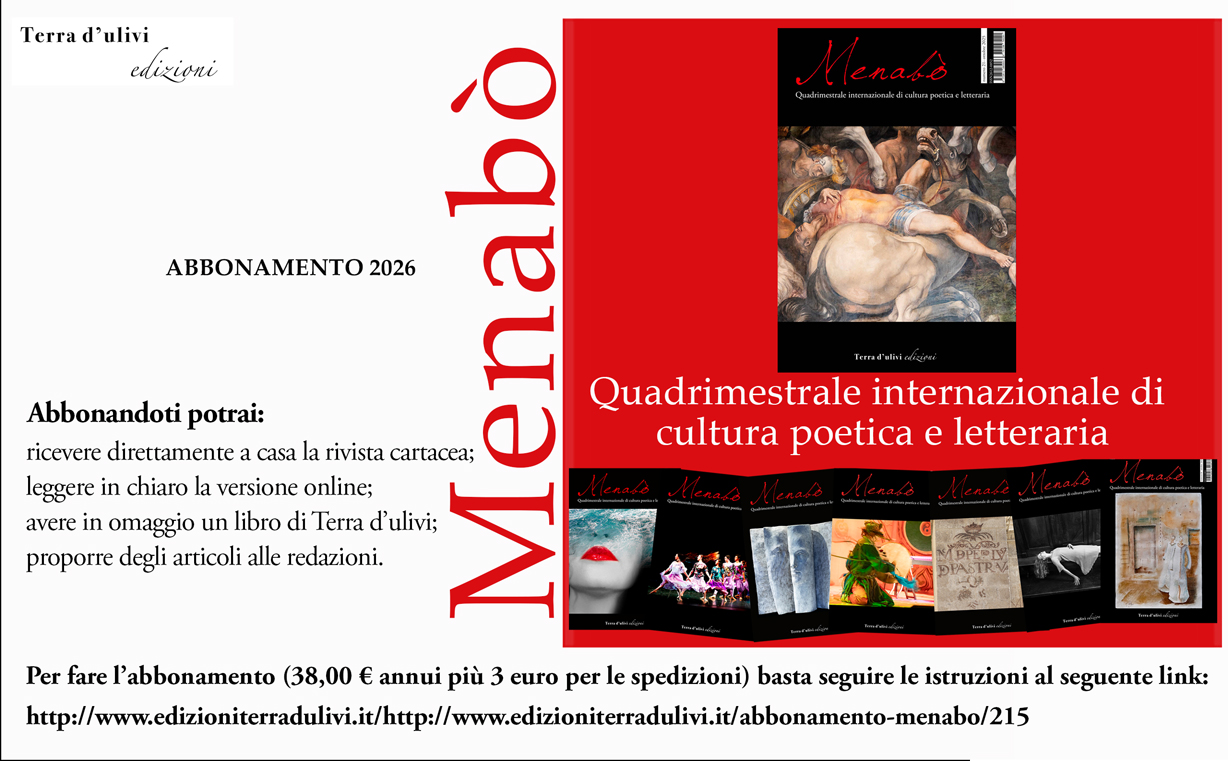
Sostienici
