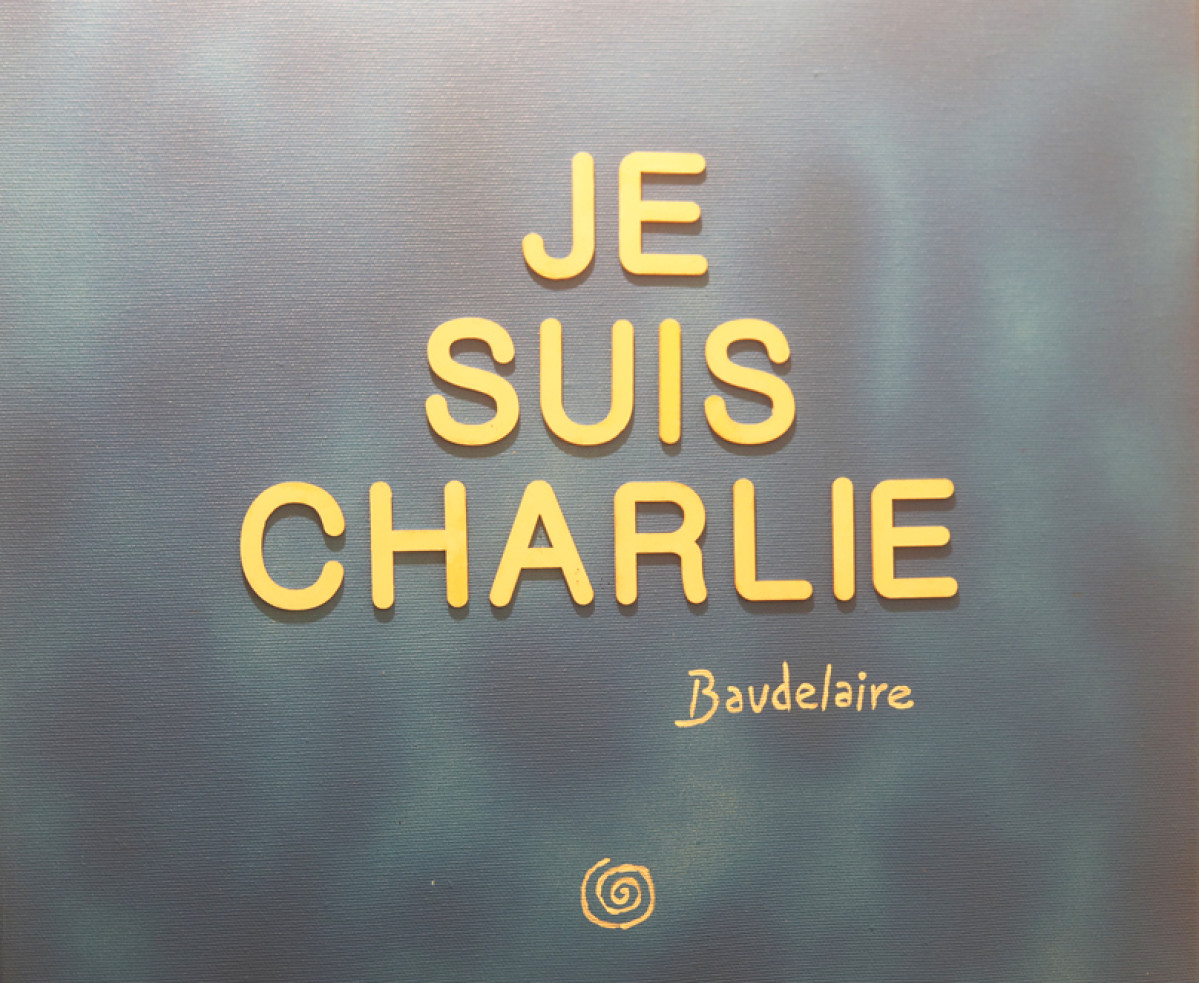
Una poesia/La poesia di Attilio Bertolucci
Dopo gli articoli dedicati a Sereni e Luzi, esponenti della linea “novecentista” di stampo ermetico/simbolista all’interno della terza generazione poetica italiana (nati tra il 1910 e il 1920), rimaniamo nell’ambito di questa generazione con un poeta che però si inserisce nella linea “sabiana” (facendo sempre riferimento alla celebre tassonomia pasoliniana): Attilio Bertolucci. Tentiamo, allora, attraverso “una poesia”, di contattare “la poesia” in questo autore di cui leggiamo un brano straordinario: «Qui all’occhio chinato», tratto dalla sua raccolta Viaggio d’inverno (1971) che Bertolucci, classe 1911, pubblica sulla soglia della vecchiaia quando «il sentimento della perdita e l’ossessione per il dissiparsi delle varie forme dell’esistenza conquistano lo spazio, un tempo protettivo, del paesaggio familiare precipitandolo in un gorgo d’ansia e spossessamento»[1] e «Il protagonista dei versi […] è come colpito da un decreto d’esproprio» [2].
Ecco il brano.
Qui all’occhio chinato erica e cardi all’occhio
levato falchi e il sole. Tu non potrai durare
a così grande splendore di metalli e silenzio. Portati
più giù presso i frutteti selvatici, i rossi sorbi
e la gente che lavora a distanza di valli sotto
il caldo che s’annuvola, lana follata, il sole
al suo tramonto vagante di rose caduche
la coperta approntata
per la notte.
(A. Bertolucci))
I primi versi tracciano, in modo meravigliosamente concreto, la frattura di un vivere sospeso tra sguardo cosmico e sentimento di precarietà dell’esistere. Si presentano immagini semplici, quotidiane, che sono però medium verso una poesia totale. I primi versi sono versi di sguardi: occhio chinato alla bellezza della terra e levato alla meraviglia del cielo. Come in alto così in basso, il cosmo si consegna allo sguardo umano attraverso, però, la ferita della finitudine. Lo «splendore di metalli e silenzio» (espressione meravigliosa) è data allo sguardo e, allo stesso tempo, è “barrata” dal senso della morte, in una temperie che «mescola e alterna alla bellezza del mondo il dolore dell’uomo» [3]. Eccolo l’uomo della modernità, “allotropo empirico-trascendentale” secondo la famosa definizione di Foucault il quale, come sintetizza Ronchi, colloca l’uomo all’interno di un perimetro di finitudine in cui l’uomo stesso appartiene all’ente come essere umano ma, al contempo, non gli “appartiene” come essere finito [4]. Qui si colloca la frattura che attraversa i primi tre versi, tratteggiando questa complessa temperie con poche immagini folgoranti legate semplicemente al movimento dello sguardo in basso e in alto. Il poeta, partecipe di questa modernità foucaultiana, rimane sospeso lungo «l’orlo dell’apparire del mondo» [5], attonito al cospetto immanente del tutto. Questi due aspetti di appartenenza/disappartenenza non trovano stasi ma, permanendo insieme, vanno a costituire il peculiare moto interiore del poeta, il suo più personale Sé come intreccio di queste due dimensioni. Il cosmo è inattingibile nella sua presenza immanente, è già perduto al suo manifestarsi: l’immanenza della natura non viene letta come possibilità di contatto assoluto, e neanche come possibilità, nell’istante, di un “naufragar” leopardiano in quel mare. È bellezza perfetta e inattingibile, segnata dalla ferita della finitudine. In questo intreccio di estasi e sconforto, risiede la vibrazione esistenziale del poeta, il suo “tono psichico”. Un intreccio che conduce al ritorno nell’alveo del quotidiano, delle attività pratiche umane. In questo stringersi ai ritmi di un mondano mesto ma rassicurante, il poeta ritrova una dimensione “storica” e “rituale” in cui inscrivere il suo cammino esistenziale. Quell’auto-esortazione «Portati più giù», che funge da cesura tra i primi versi “cosmici” e la successiva partitura, assume i tratti di una vera e propria dichiarazione di poetica: un ridimensionamento rispetto al sublime, una rinuncia all’assoluto della natura, la ricerca sommessa di un rifugio “antropologico”. I ritmi del lavoro, le valli, la «lana follata» delle nubi, «la coperta approntata» del cielo al tramonto: la natura si umanizza, acquisisce i tratti della protezione, del conforto, si spoglia dell’assoluto, della potenza cosmica. Il poeta sembra rifugiarsi nel mondo dell’umano, in una dolce malinconia su cui campeggia l’immagine davvero superba del tramonto «vagante di rose caduche», formula che ripropone l’indissolubile e irrisolta duplicità di cui abbiamo detto, ma che qui ci giunge musicale, nella dissonanza lieve dei due aggettivi, come palmi che ci consegnano queste rose che già si dissipano in coperta notturna, che avvolge il mondo, e lo cancella. Simbolo concreto, tattile, di una poetica dell’ambivalenza dell’esistere, del perpetuo tramonto, della luce che “crepuscolarmente” già evoca la notte, che sembra contenerla come un nocciolo sempre presente nella sua irriducibilità.
________________________
[1] E. Testa, Dopo la lirica, Poeti italiani 1960-2000 (Einaudi, 2005) p. 62.
[2] ivi.
[3] ivi.
[4] R. Ronchi, Il canone minore, Feltrinelli (2017), ed. Kindle pos. 2075, mia sintesi.
[5] œbid. pos.2115
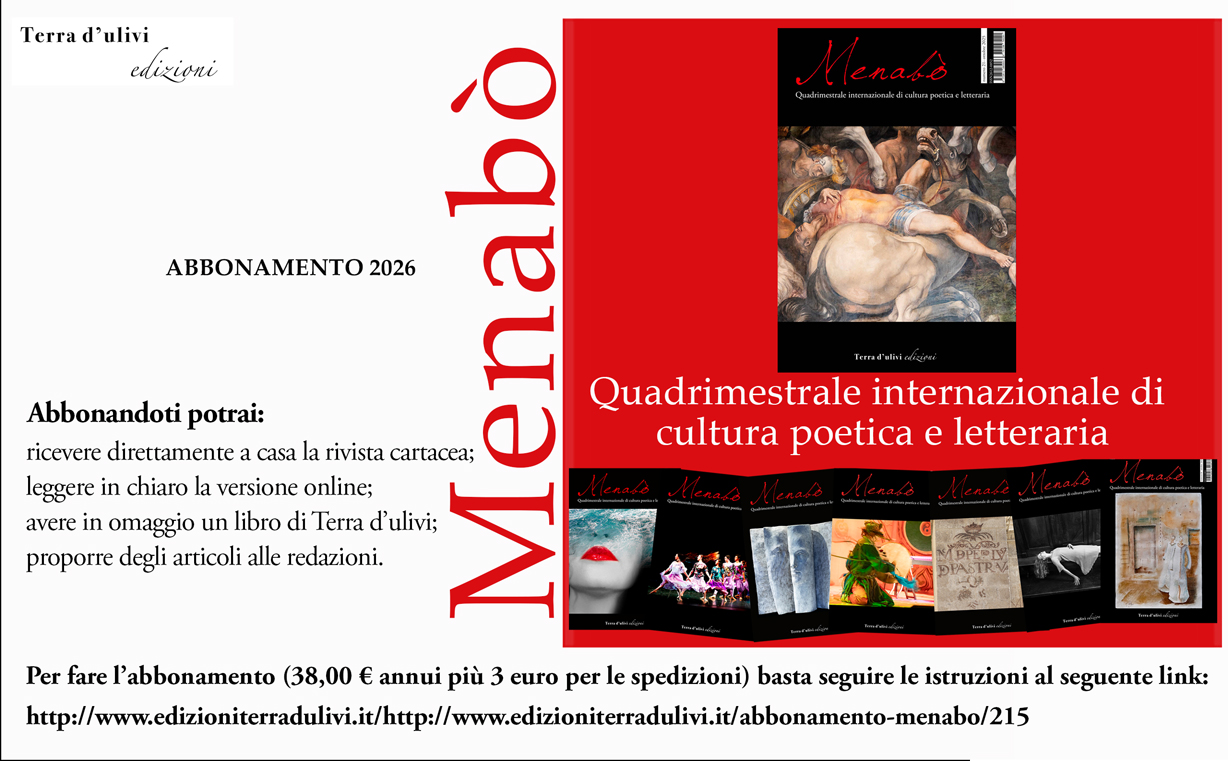
Sostienici

Lascia il tuo commento