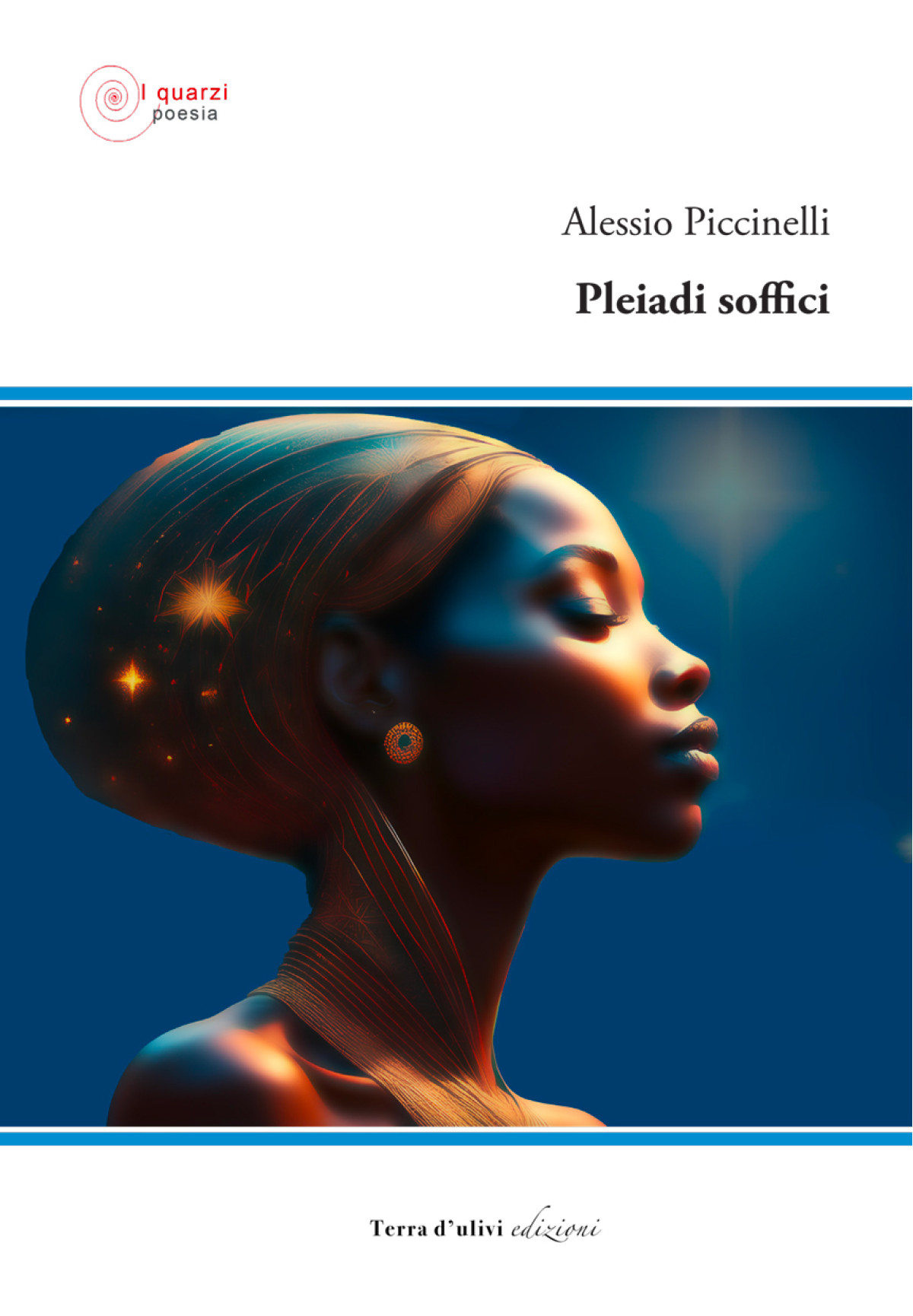
“Pleiadi soffici” di Alessio Piccinelli – Metafisica di un’anima
L’opera di Alessio Piccinelli si distingue collocandosi, sin dal titolo, in una dimensione metempirica dove il cielo delle idee si mescola alla polvere terrestre dei ricordi. Si tratta di una raccolta che sembra giungere da un altrove rarefatto, in cui la parola non descrive, ma allude; non spiega, ma suggerisce. L’ ermetismo che la attraversa non è cifra di oscurità, bensì la forma più autentica di una verità dolorosa, incastonata nei frammenti di un vissuto intimo e complesso.
I componimenti si muovono seguendo un ordine musicale, come uno spartito che tenta di restituire armonia a un’esistenza percossa dal lutto e dal senso di assenza. In questa costellazione familiare dolente, la morte giganteggia come astro sovrano, imponendo le sue leggi di malinconia e silenzio. Eppure, è proprio dentro quel vuoto che la parola vede articolarsi le sua necessità, il proprio respiro: la scrittura diviene un’altra forma di solitudine, un modo per abitarci dentro talvolta provando a non soccombere, talvolta semplicemente lasciandosi andare.
I luoghi che vivono fra i versi, le stanze, i tavoli gocciolanti, le finestre aperte sui paesaggi corrosi, sono specchi dell’interiorità che li anima. La natura appare, infatti, insieme madre e carnefice, in una doppia veste che divora, spolpa, lascia brandelli di vita sotto un sole assassino trasfigurante anche la primavera, stagione ammuffita, un miraggio di rinascita che s’intravede ma si rimanda. Le immagini si sovrappongono, si contraddicono, si respingono a vicenda: in esse si consuma il conflitto degli opposti, dove la quiete anela la tempesta e il sonno si confonde con la paranoia.
Piccinelli scrive sporgendosi da una soglia fragile, tra l’impulso alla dissoluzione e il desiderio di un contatto umano, tra la preghiera respinta e la parola che ancora riesce a rischiarare comparti di realtà. La sua poetica, che frettolosamente potrebbe essere tacciata di pessimismo e scoramento, medita invece sulla materia cupa del dolore, riprendendo però quella luce minuta che serpeggia costante, cogliendo un bagliore di commozione a illuminare l’ombra. È la presenza (forse dei morti, forse dei vivi) che torna a farsi sentire nel canto di un uccello, nel profumo dei limoni, nel tenero colore del cielo.
L’esperienza della perdita si apre al dialogo continuo con ciò che resta. Gli alberi diventano testimoni, lasciti silenziosi di un amore che non può concedersi la parola ‘fine’, ma si insinua, nonostante tutto, nella persistenza di ciò che, pur dissolto, continua a brillare in un canto sommesso e lucente, come il riflesso di una stella sul fondo di un bicchiere.

Sostienici

Lascia il tuo commento