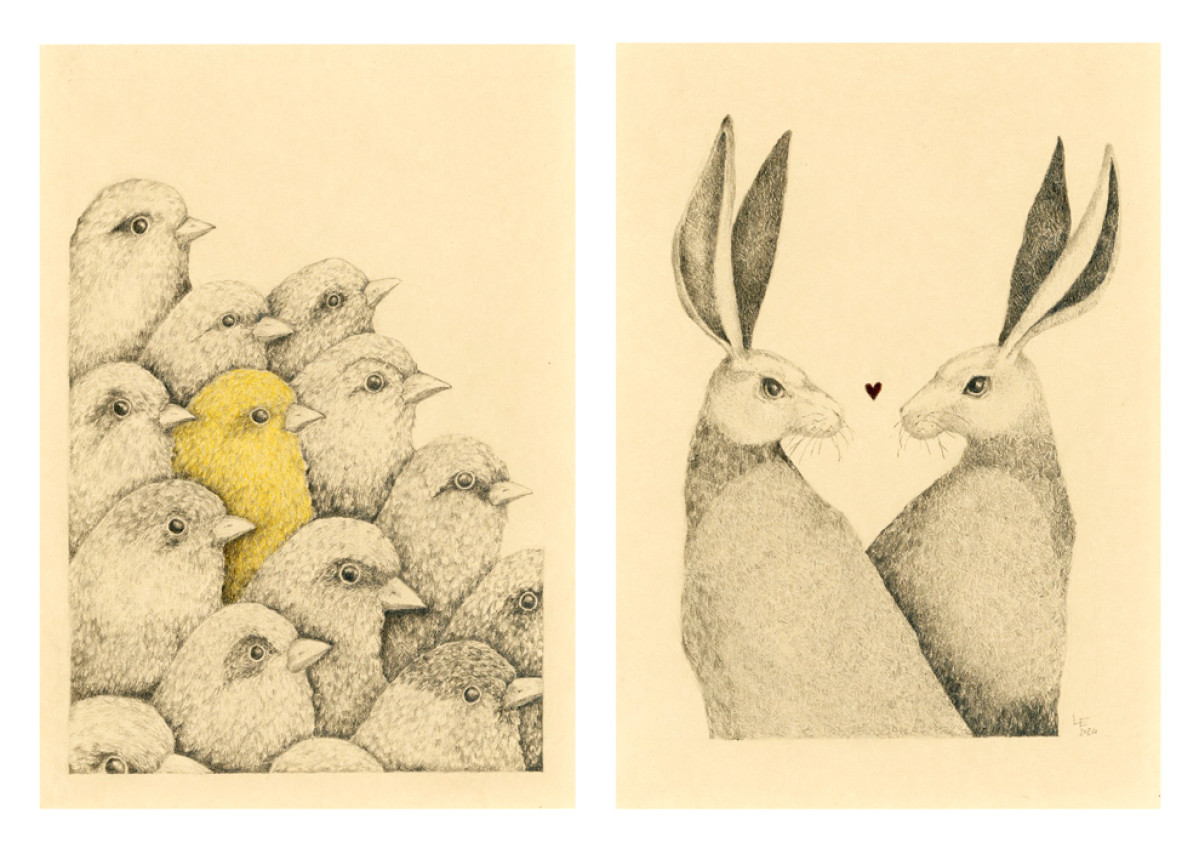
Una poesia/La poesia di Mario Luzi
Attraverso “una poesia” contattare “la poesia” in Mario Luzi. Un tentativo di entrare verticalmente, nello spazio circoscritto di un breve articolo, nel complesso mondo poetico di questo autore attraverso la lettura di un suo brano straordinario. Il brano in questione è «È, l'essere. È.», tratto dalla sua raccolta Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini (1994) che Luzi, classe 1914, pubblica in tarda età, in quello che Testa definisce il «quarto momento della storia poetica luziana[1]» caratterizzato da «corrosione di metro e sintassi [2]». Una scrittura che, in questa ultima fase del suo percorso, si fa essenziale, ieratica, altissima.
Ecco il brano.
È, l'essere. È.
Intero,
inconsumato,
pari a sé.
Come è
diviene.
Senza fine,
infinitamente è
e diviene,
diviene
se stesso
altro da sé.
Come è
appare.
Niente
di ciò che è nascosto
lo nasconde.
Nessuna
cattività di simbolo
lo tiene
o altra guaina lo presidia.
O vampa!
Tutto senza ombra flagra.
È essenza, avvento, apparenza,
tutto trasparentissima sostanza.
È forse il paradiso
questo? oppure, luminosa insidia,
un nostro oscuro
ab origine, mai vinto sorriso?
(M. Luzi)
Il brano si dichiara già nel primo verso nel suo intento “impossibile” di dire semplicemente l’essere. Di cui, come subito ci avverte il poeta, si può in fondo solo dire che è. Immediatamente emerge, dalla semplicità dei versi, l’Uno plotiniano in una concezione moderna, come puro atto in atto della vita in sé, tipica della filosofia del vitalismo, dell’immanenza assoluta, che Rocco Ronchi definisce la “linea minore” del pensiero [3]. Un Uno che non è concepito come trascendenza, come essere divino in senso “tradizionale”, ma che abita una dimensione di infinito “in due sensi”, assoluto in sé e, al contempo, causa dell’infinità molteplice. Come esprime perfettamente Luzi «diviene / se stesso / altro da sé», si diversifica nella moltitudine del mondo rimanendo intero, inconsumato. Il poeta sa che sta menzionando qualcosa per cui non vi è parola: non una quidditas, di cui si possa fare una descrizione perché dell’ordine del simbolico, che possa essere disvelata da un atto di pensiero, un qualcosa «che è nascosto» e che venga portato alla luce della ragione. Non c’è una «cattività di simbolo» (espressione meravigliosa) che lo inguaini, che lo contenga. È un fuori assoluto, una pura quodditas, di cui si può dire solo “che è”. E questo fa il poeta, adottando uno stile “presentativo [4]”, indicando più che esprimendo. Una «vampa» di pura esistenza «senza ombra», senza bordi, che non si offre alla cattura del pensiero. La poesia tenta la strada impossibile del nominare ciò che è oltre il logos, pur collocandosi – il suo gesto espressivo – inevitabilmente nel dominio della parola. Procede per astrazione estrema verso la descrizione di quella emozione poetica come «sensazione di universo» di cui ci parla Valery [5] e che già Leopardi ha intuito nel suo Infinito come esperienza di contatto profondo con l’Uno della natura naturans.
Nella parte finale, altissima, il poeta ci interroga direttamente – stilema tipico di questo suo periodo [6] – esprimendo, nella domanda che chiude la poesia, l’ambiguità profonda che attraversa l’esperienza dell’umano di fronte all’immanenza, tra l’invincibile tensione verso la categorizzazione e il suo superamento radicale. C’è la tentazione di nominare questa esperienza assoluta all’interno di una categoria trascendente e pacificante: il «paradiso». Ma il poeta va immediatamente oltre: sembra indicarci, come articolazione di questo contatto con il reale, il completo abbandono all’attualità di una pura istanza che ci si presenta inaggirabile e incomprensibile. Una “nostra” pulsione che ci precede, che precede ogni coscienza («ab origine»), un ripetersi senza fine della nostra inafferrabile jouissance [7] lacaniana, un Uno che si perpetua, che in definitiva è ciò che siamo, la nostra più propria ed essenziale appartenenza al reale in quanto singolare partecipazione alla sostanza, unica e molteplice al contempo, che è il Tutto. Questo nostro pulsare – il più profondo e originario – che il poeta menziona in una intuizione espressiva straordinaria come «mai vinto sorriso». Il sorriso unico e singolare del neonato di deleuziana memoria [8], l’essere noi all’origine puri viventi inscritti nell’immanenza assoluta della vita. Una tensione religiosa nel senso più proprio del termine, di un legame tra tutte le cose, espressa «con toni tra profezia e preghiera [9]». Una parola dell’Uno, dell’esperienza come divenire che è creazione continua, durata, processo: «Dio non è nient'altro che il nome convenzionale per l'atto "intemporale" del vivere che circola in ogni vita, è il nome del vivente in quanto vivente, per il vivente "che" vive, per tale "quodditas" anteriore a ogni "quidditas" [10]».
__________________________________
[1] E. Testa, Dopo la lirica, Poeti italiani 1960-2000 (Einaudi, 2005) p. 45.
[2]. ivi.
[3]. R. Ronchi, Il canone minore, Feltrinelli (2017).
[4]. Testa, op. cit. p. 46.
[5]. P. Valéry, Necessità di poesia (Spider&Fish, 2020) curato da P. Imperio, che raccoglie una serie di saggi di Valéry, p. 26-27.
[6]. Testa, op. cit., p. 46.
[7]. “Godimento” nell’accezione lacaniana collegata all’Uno della pura esistenza, come chiarito nelle frasi successive.
[8] «I neonati si somigliano tutti e non possiedono affatto individualità; ma hanno singolarità, un sorriso, un gesto, una smorfia» (da L’immanenza, una vita…di G. Deleuze).
[9]. Testa, op. cit. p. 46.
[10] Ronchi, op. cit., edizione kindle, pos. 4772.
Sostienici

Lascia il tuo commento